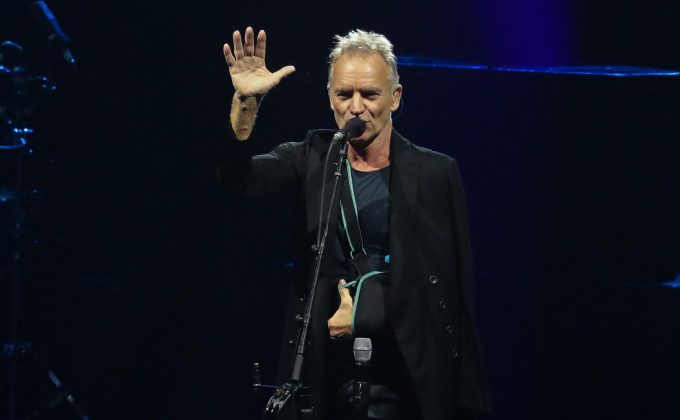Articoli
I LOCALI SIMBOLO DELLA SOCIALIZZAZIONE.
- Dettagli
- Scritto da Marco Morelli
Sono, e sono stati sin dalla loro invenzione, non solo confortevoli ambienti in cui concedersi un breve relax, ma fucine per eccellenza di relazioni sociali. Non c'è film dove prima o poi non vi sia una scena ambientata in essi, li troviamo immortalati in inestimabili quadri d'autore e celebrati in romanzi di altrettanta fama. Che si tratti di anonimi locali di campagna, o di aristocratici ambienti alla moda, di minuscoli esercizi in cui consumare rapidamente in piedi o di chiassose e allegre birrerie allietate da musica, sono luoghi in cui ci si godono le amicizie e dove si cementano gli affari, luoghi di ispirazione filosofica e musicale, luoghi di avvio e di conclusione di storie amorose, insomma luoghi di progetti di vita di ogni tipo. Che si chiamino "Caffè", "Bar" o "Pub" poco importa; la loro funzione e l'intreccio di vite che ovunque li animano sono di pari riscontro sociale. E la loro coloritissima storia ha origini antichissime. Non vi sono tracce di locali affini nell'antica Grecia, essendo il simposio ellenico una consuetudine privata e non alla mercé di tutti, ed i reperti archeologici reperiti recentemente in Mesopotamia, riconducibili ad una presunta locanda, non vanno oltre suggestive ipotesi. Ma nell'Urbe i locali pubblici proliferavano: Roma è stata maestra di civiltà anche in questo. Il thermopolium (derivato dal greco thermòs, "caldo", e pōlèō, "vendo") era infatti il luogo di ristoro in uso nell'antica Roma, dove era possibile acquistare e consumare bevande calde e a volte anche cibo pronto per il consumo. Era costituito da un locale di piccole dimensioni, con un bancone nel quale erano incassate grosse anfore di terracotta, chiamate dolii o dolia, atte a contenere le vivande. Il thermopolium viene descritto in vari testi, e soprattutto venne suo malgrado immortalato dall'eruzione vulcanica del Vesuvio: a Pompei ne esiste uno quasi integro, e altri due tra le rovine di Ercolano e di Ostia Antica. Avevano inequivocabilmente una funzione simile ai moderni bar. Si parte quindi dai Romani, attraverso le sporche bettole medioevali e le fumose locande rinascimentali, per arrivare ai bar e pub moderni, oggi perfetta fusione di mondanità e comfort.
Ma da dove deriva la parola "bar"? Si fanno molte ipotesi. Secondo alcuni "bar" sarebbe una contrazione di "barrier", ovvero "sbarra" in inglese, il bancone che divide il gestore dalla clientela. In Italia invece la parola bar sarebbe l'acronimo di "Banco A Ristoro", introdotto a Firenze sul finire del 1800. "Pub" invece sta per public house (edificio pubblico), denominazione dei locali per antonomasia del Regno Unito, e poi diffusi in tutto il mondo. E' d'uopo però fare un salto indietro nel tempo, e partire dal predecessore dei "bar" o "pub" moderni: il "caffè". Affinché la bevanda da bar per eccellenza, il caffè, approdasse in questi esercizi, bisogna far riferimento alla civiltà turca. Già nel 1500, in Medio Oriente, si consumavano the e caffè in alcuni luoghi di ritrovo, e davanti alle tazze fumanti si incontravano artisti e uomini d'affari. Un concetto di "luogo aperto", dove vedersi lontano da casa, per consumare bevande pregiate e ridere, pensare e discutere, che fu importato in "occidente" a cavallo tra il 1600 ed il 1700. È in quegli anni che fanno la loro comparsa a Vienna, in Austria, e a Venezia, in Italia, le prime caffetterie, divenute poi celebri anche a Padova, Firenze e Roma. Il boom si ebbe soprattutto quando il Papato abolì il divieto di consumare il caffè. All'Italia, seguì poco tempo dopo anche la Francia, con Parigi. Nel 1900 in Italia iniziò a scomparire la scritta "Caffè" a favore di "Bar". Da luogo elitario divenne sempre più popolare: qui si riunivano non solo politici, attori ed artisti, ma anche persone di ogni ceto sociale. Fu definitivamente scelto dagli italiani come luogo chiave per cominciare la giornata negli anni del boom economico; tra il 1950 e il 1960 andavano tutti di corsa a lavorare e si passava al bar per gustare un caffè veloce per poi scappare via.
Come sopra detto, sin dal XVI secolo, le caffetterie (qahveh-khaneh in persiano) hanno assolto la funzione di luogo di intrattenimento socializzante nelle regioni del medio oriente, dove gli uomini si riunivano per consumare caffè o tè, ascoltare musica, leggere e per ascoltare narrazioni. Nel XVII secolo i caffè apparvero per la prima volta in Europa attraverso i porti del Mediterraneo che commerciavano con il medio oriente, come Venezia e Marsiglia, e attraverso i porti del Mare del Nord che dominavano il commercio mondiale, come Londra e Amsterdam. Questi locali d'incontro e socializzazione divennero ben presto i luoghi di ritrovo preferiti per filosofi e studiosi, per artisti e politici. Il Settecento fu il "periodo d'oro" dei caffè europei: essi erano il ritrovo della emergente borghesia in opposizione ai salotti aristocratici ed ovviamente alle osterie e birrerie popolari. I caffè furono quindi i luoghi centrali nella vita commerciale e culturale delle città europee, dove si svilupparono i principali aspetti della società borghese. Nel 1739 si contavano ben 551 coffee house nella sola città di Londra. Ognuno di essi richiamava una determinata categoria di frequentatori; in alcuni si ritrovava il mondo politico, in altri quello commerciale, bancario o assicurativo, in altri ancora il mondo letterario ed artistico. Similmente, alla fine del Settecento a Parigi c'erano quasi 3.000 cafés. Anche i caffè italiani furono luoghi di discussioni letterarie e politiche, tanto che la più importante rivista dell'Illuminismo italiano si chiamava proprio Il Caffè. In molti paesi europei alle donne era vietato l'ingresso nei caffè: in Germania era loro consentita la frequentazione, ma in Francia ed in Gran Bretagna alle signore era vietato entrare in questi locali. Invece a Venezia le signore li frequentavano abitualmente.
Nell' Ottocento e nel Novecento i Caffè hanno visto una lenta progressiva evoluzione sia funzionale che stilistica. Iniziarono ad aprire molti nuovi caffè eleganti in tutta Europa, nei luoghi più belli e di richiamo delle città. In questo periodo ad esempio nacquero i caffè viennesi con la loro atmosfera tranquilla ed i loro rituali (famoso il Sacher), come pure i caffè parigini, dotati di grandi vetrine e terrasses dove sedere indisturbati al tavolino osservando la vita cittadina (il Café de la Paix esiste tuttora). In Italia furono soprattutto le piazze a riempirsi dei tavolini dei caffè: sotto i portici della piazza principale di tante città e cittadine esercitavano la propria attività almeno due caffè "rivali", i cui nomi si ripetevano simili da una cittadina all'altra, come "Caffè Nazionale" e "Caffè Commercio". Proprio nel Novecento, nella Belle Epoque, molti locali europei frequentati dai più grandi letterati ed artisti del mondo (Picasso, Hemingway, ecc.) sono diventati simboli della storia intellettuale mondiale, veri e propri monumenti dell'evoluzione dell'uomo. In Italia i caffè sono rimasti in auge fino alle soglie del "miracolo economico" degli anni '60. Successivamente i caffè storici sono sopravvissuti, ma non ne sono stati più aperti di nuovi; nel contempo si affermavano altri tipi di esercizi, in particolare i bar, che (in Italia) si sono specializzati nella preparazione del caffè espresso servito al bancone.
E si arriva così al Duemila. Nel mondo il "Bar" prende piede in modo perentorio, con le sue varie "specializzazioni". In Italia il cosiddetto "Bar all'italiana", in grande auge sino alla fine del secolo scorso, perde via via le sue prerogative del dopoguerra (il gioco delle carte, il tavolo da biliardo, la ricevitoria di lotterie, i giochi elettronici, ecc.). I locali si modernizzano, la clientela si ringiovanisce drasticamente, gli esercizi e gli arredi diventano più eleganti e funzionali, più inclini alla redditività, pur rimanendo i luoghi di aggregazione sociale più ambiti. A cavallo tra il XX e il XXI secolo in viarie parti del mondo si è assistito alla nascita di bar tematici e stravaganti, come ad esempio in Giappone i manga café dedicati ai fumetti o i neko café che offrono ai clienti la possibilità di interagire con i gatti ospitati dal locale. Altri bar, oltre alle classiche consumazioni, danno alla clientela la possibilità di accedere a servizi specifici, come gli americani: Internet cafè, con dotazioni di computer, gay bar, rivolti ad un pubblico omosessuale, topless bar, in cui le cameriere servono i clienti a seno scoperto, lounge bar, eleganti e con dotazione di intrattenimento musicale, e innumerevoli altre varianti. L'american bar, destinato principalmente al consumo di cocktail, si è un po' defilato.
I bar europei li conosciamo bene, ma è così ovunque nel resto del mondo non occidentale? Australia. In Australia, la principale forma di vendita commerciale di alcolici autorizzata dal periodo coloniale ad oggi è stata il pub, una variante locale dell'originale pub inglese. Fino agli anni '70, i pub australiani erano tradizionalmente organizzati in aree per bere divise per genere: il pub era aperto solo agli uomini, mentre i "lounge bar" o i "saloon bar" servivano sia uomini che donne (cioè bevande miste). Questi locali furono molto popolari tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70 e molti offrivano intrattenimento gratuito, diventando un aspetto importante della scena musicale di Sydney in quel periodo. Nelle principali città australiane oggi c'è una scena di bar ampia e diversificata con una gamma di ambienti, modalità e stili adatti a ogni livello della sua società cosmopolita. Cina. Se pensate di andare in Cina e, tra un'escursione e l'altra, potervi avvalere del breve ristoro di un bar, scordatevelo. In Cina i bar non sono mai esistiti e non esistono tuttora, salvo ovviamente i locali di chiaro stampo europeo realizzati nelle città maggiori per accogliere il turismo. La civiltà cinese ora avanza in modo travolgente, ma, dopo il crollo dell'epoca maoista che aveva azzerato il periodo opulento del colonialismo europeo, per la ristorazione siamo agli albori. India. Col suo miliardo e mezzo di abitanti pareggia la Cina, ma qui il colonialismo inglese non ha mai perduto certe sue prerogative. Si perde il conto dei locali popolari in ogni centro urbano, con livelli estetici ed igienici discutibili; locali però più dedicati a forme di ristorazione spicciola e spartana che non ha luoghi esclusivamente di ritrovo. Ad essi si affiancano ovunque locali di eccellente livello, riservati alla fascia sociale più abbiente. Africa. Qui si trovano i "bar" più coloriti, quelli che conducono al buonumore. Sorgono lungo le rare arterie stradali. Un tavolo a far da bancone, una ghiacciaia come frigo in quelli più all'avanguardia, e tre-quattro tipi di bibite in lattina come scelta per gli avventori, in genere Coca-Cola e birra. Latte di noci di cocco e banane come corollario. Nella povera società subequatoriale africana, in cui il concetto di "ritrovo" è inglobato nella vita comunitaria del villaggio, il termine "bar" non racchiude alcun significato, se non quello di fonte di "guadagno" dai rari viandanti o turisti.
Tornando a noi, come saranno i bar del nuovo millennio? Non si sa, ma certamente quello che avrà il successo più travolgente sarà il primo che verrà aperto nello spazio.