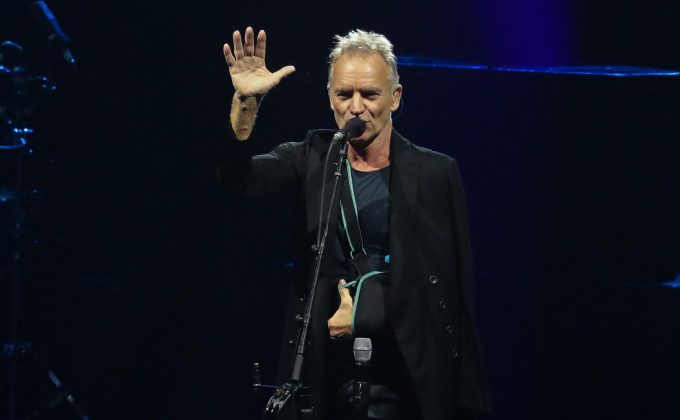SAN BENEDETTO IN POLIRONE: UNA CHIESA TUTTA DA SCOPRIRE
- Dettagli
- Scritto da Marco Morelli
 Chi entra oggi nella chiesa di San Benedetto Po spesso non immagina che questo grande edificio, monumentale come pochi altri in pianura, è diventato una chiesa parrocchiale solo in un secondo momento. Per secoli è stato il cuore spirituale di un'abbazia benedettina tra le più potenti dell'Italia settentrionale che qualcuno ha definito "La Montecassino del Nord". Poi arrivò Napoleone e bastò una firma per sopprimere il monastero e disperdere i monaci: era il 9 marzo del 1797. Fu allora che si decise di demolire l'antica chiesa parrocchiale di San Floriano conservandone solo il campanile. La chiesa dell'abbazia divenne allora quella del paese di San Benedetto Po ma basta osservarne le dimensioni e la facciata per capire che la sua storia veniva da lontano, da molto lontano.
Chi entra oggi nella chiesa di San Benedetto Po spesso non immagina che questo grande edificio, monumentale come pochi altri in pianura, è diventato una chiesa parrocchiale solo in un secondo momento. Per secoli è stato il cuore spirituale di un'abbazia benedettina tra le più potenti dell'Italia settentrionale che qualcuno ha definito "La Montecassino del Nord". Poi arrivò Napoleone e bastò una firma per sopprimere il monastero e disperdere i monaci: era il 9 marzo del 1797. Fu allora che si decise di demolire l'antica chiesa parrocchiale di San Floriano conservandone solo il campanile. La chiesa dell'abbazia divenne allora quella del paese di San Benedetto Po ma basta osservarne le dimensioni e la facciata per capire che la sua storia veniva da lontano, da molto lontano.
Il sagrato, la facciata e i 12 apostoli
La facciata della chiesa attuale è stata realizzata su progetto di Giulio Romano che invitato dall'abate Gregorio Cortese porta il rinascimento al Polirone. E' un loggiato a serliane che era sormontato da timpani triangolari. Il loggiato aereo attuale al centro della facciata è stato realizzato nel '700 per proteggere l'organo della controfacciata dalle infiltrazioni. Davanti alla chiesa si apre un sagrato delimitato da una balaustra su cui sono poste le statue dei 12 apostoli. Oggi è la piazza del paese ed è difficile pensare che un tempo questa corte monastica fosse chiusa agli esterni ma lo si capisce se si osserva al termine dei portici il voltone che era l'ingresso del monastero e la cui facciata si trova dalla parte opposta.
Dentro la navata: il lifting di Giulio Romano
Quando si entra si ha la sensazione di essere in una chiesa del Cinquecento. Ma è un'illusione ben studiata. Sotto le serliane che separano le navate si nasconde infatti la struttura gotica. Giulio Romano decide di mascherare l'impianto medievale con un maquillage architettonico che decora anche le volte a crociera: il gotico non era più di moda e l'allievo di Raffaello fa quello che oggi chiameremmo un restyling completo.
San Simeone e la fortuna del monastero
A sinistra dell'ingresso c'è la cappella che ospita il corpo di San Simeone, eremita arrivato a San Benedetto poco dopo la sua fondazione nel 1007 e che morirà il 26 luglio del 1016. Bonifacio di Canossa riuscirà a farlo canonizzare dal papa nel 1024. Per un monastero avere un santo all'interno della chiesa era una sorta di calamita per i pellegrini e per le offerte dei fedeli. Di fianco all'ingresso della cappella una statua in terracotta rappresenta San Simeone con la cerva, uno dei suoi attribti e che diventerà anche il simbolo di San Benedetto in Polirone.
Antonio Begarelli: statue in terracotta di santi per un paradiso in terra
Chi passeggia tra le cappelle laterali della chiesa viene osservato da figure a grandezza naturale che sembrano voler scendere dalle nicchie che le ospitano. Sono le statue in terracotta dello scultore oblato benedettino Antonio Begarelli. Realizzate presso il monastero rappresentano santi della tradizione benedettina e non solo. Tra le più belle ricordiamo quella di San Giorgio e il drago e di Sant'Antonio abate che qui non ha il porcellino al fianco ma il fuoco detto di Sant'Antonio appunto. Un tempo erano ricoperte di bianco per farle sembrare di marmo ma oggi che hanno recuperato il caldo colore della terracotta sono ancora più belle.
Il coro dei monaci
Oggi il coro si intravede nello spazio che viene circondato dal deambulatorio, il corridoio che percorre tutta la lunghezza dell'abside della chiesa. E' un capolavoro di intaglio cinquecentesco che rimanda subito all'immagine dei monaci che cantano le lodi del signore. La sua collocazione originaria era speculare rispetto a quella attuale e copriva completamente ai fedeli la vista dell'altar maggiore così come succedeva di regola nelle abbazie benedettine.
La chiesa di Santa Maria: Matilde di Canossa sepolta al Polirone
Alla fine della navata sinistra e all'inizio del deambulatorio si entra nella chiesa di Santa Maria, uno dei luoghi più antichi dell'abbazia. Fu qui secondo la tradizione che chiese di essere sepolta Matilde di Canossa morta il 24 luglio 1115 e qui transitavano i corpi dei monaci defunti per l'ultimo saluto. Sul pavimento della chiesetta, rinnovata poi nel periodo barocco, rimane un mosaico pavimentale dove si mette in scena la lotta tra vizi e virtù, una metafora dell'impegno della Gran Contessa a favore della chiesa. La sepoltura di Matilde fu poi spostata ma in questo luogo si respira ancora l'atmosfera del monastero delle origini.
Il sepolcro di Matilde senza Matilde
Di fianco alla sagrestia troviamo invece l'ultimo luogo di sepoltura di Matilde di Canossa. Oggi è un sepolcro vuoto coronato da un quadro di Orazio Farinati che rappresenta la gran contessa a cavallo con una melagrana in mano. La leggenda vuole che all'interno del sepolcro sia rimasta solo una delle pantofole di Matilde, il cui corpo fu venduto dai monaci del Polirone nel 1633 a papa Urbano VIII Barberini, per rimpinguare le casse vuote del monastero a seguito della peste portata dai Lanzichenecchi. Oggi Matilde riposa nella basilica di San Pietro a Roma in un sepolcro segnalato dal monumento funebre realizzato da Bernini.
Il campanile: la serliana che suona le ore
Giulio Romano ha lasciato la sua firma anche sul campanile dell'abbazia, elemento iconico dell'intero complesso. Alto, robusto, in mattoni, custodisce una cella campanaria decorata con una serliana: tre aperture con arco centrale che alleggeriscono la struttura e la rendono elegante. È un dettaglio raffinato che troviamo in altri luoghi del monastero come ad esempio nella navata centrale della chiesa o nell'atrio della biblioteca monastica.
Una chiesa che è una macchina del tempo
La chiesa abbaziale di San Benedetto in Polirone è molto più di un edificio religioso: è una macchina del tempo che ci porta dal Medioevo all'età moderna, da Matilde di Canossa a Giulio Romano, dai monaci benedettini ai parroci del Novecento. È un luogo in cui l'arte e la storia si sono date appuntamento, e dove ogni pietra ha qualcosa da raccontare. Se non ci siete mai stati, andateci. Se ci siete già stati, tornateci. Perché qui, ogni volta, si scopre qualcosa di nuovo.
IN APERTURA FOTO CARLO PERINI
I LOCALI SIMBOLO DELLA SOCIALIZZAZIONE.
- Dettagli
- Scritto da Marco Morelli
 Sono, e sono stati sin dalla loro invenzione, non solo confortevoli ambienti in cui concedersi un breve relax, ma fucine per eccellenza di relazioni sociali. Non c'è film dove prima o poi non vi sia una scena ambientata in essi, li troviamo immortalati in inestimabili quadri d'autore e celebrati in romanzi di altrettanta fama. Che si tratti di anonimi locali di campagna, o di aristocratici ambienti alla moda, di minuscoli esercizi in cui consumare rapidamente in piedi o di chiassose e allegre birrerie allietate da musica, sono luoghi in cui ci si godono le amicizie e dove si cementano gli affari, luoghi di ispirazione filosofica e musicale, luoghi di avvio e di conclusione di storie amorose, insomma luoghi di progetti di vita di ogni tipo. Che si chiamino "Caffè", "Bar" o "Pub" poco importa; la loro funzione e l'intreccio di vite che ovunque li animano sono di pari riscontro sociale. E la loro coloritissima storia ha origini antichissime. Non vi sono tracce di locali affini nell'antica Grecia, essendo il simposio ellenico una consuetudine privata e non alla mercé di tutti, ed i reperti archeologici reperiti recentemente in Mesopotamia, riconducibili ad una presunta locanda, non vanno oltre suggestive ipotesi. Ma nell'Urbe i locali pubblici proliferavano: Roma è stata maestra di civiltà anche in questo. Il thermopolium (derivato dal greco thermòs, "caldo", e pōlèō, "vendo") era infatti il luogo di ristoro in uso nell'antica Roma, dove era possibile acquistare e consumare bevande calde e a volte anche cibo pronto per il consumo. Era costituito da un locale di piccole dimensioni, con un bancone nel quale erano incassate grosse anfore di terracotta, chiamate dolii o dolia, atte a contenere le vivande. Il thermopolium viene descritto in vari testi, e soprattutto venne suo malgrado immortalato dall'eruzione vulcanica del Vesuvio: a Pompei ne esiste uno quasi integro, e altri due tra le rovine di Ercolano e di Ostia Antica. Avevano inequivocabilmente una funzione simile ai moderni bar. Si parte quindi dai Romani, attraverso le sporche bettole medioevali e le fumose locande rinascimentali, per arrivare ai bar e pub moderni, oggi perfetta fusione di mondanità e comfort.
Sono, e sono stati sin dalla loro invenzione, non solo confortevoli ambienti in cui concedersi un breve relax, ma fucine per eccellenza di relazioni sociali. Non c'è film dove prima o poi non vi sia una scena ambientata in essi, li troviamo immortalati in inestimabili quadri d'autore e celebrati in romanzi di altrettanta fama. Che si tratti di anonimi locali di campagna, o di aristocratici ambienti alla moda, di minuscoli esercizi in cui consumare rapidamente in piedi o di chiassose e allegre birrerie allietate da musica, sono luoghi in cui ci si godono le amicizie e dove si cementano gli affari, luoghi di ispirazione filosofica e musicale, luoghi di avvio e di conclusione di storie amorose, insomma luoghi di progetti di vita di ogni tipo. Che si chiamino "Caffè", "Bar" o "Pub" poco importa; la loro funzione e l'intreccio di vite che ovunque li animano sono di pari riscontro sociale. E la loro coloritissima storia ha origini antichissime. Non vi sono tracce di locali affini nell'antica Grecia, essendo il simposio ellenico una consuetudine privata e non alla mercé di tutti, ed i reperti archeologici reperiti recentemente in Mesopotamia, riconducibili ad una presunta locanda, non vanno oltre suggestive ipotesi. Ma nell'Urbe i locali pubblici proliferavano: Roma è stata maestra di civiltà anche in questo. Il thermopolium (derivato dal greco thermòs, "caldo", e pōlèō, "vendo") era infatti il luogo di ristoro in uso nell'antica Roma, dove era possibile acquistare e consumare bevande calde e a volte anche cibo pronto per il consumo. Era costituito da un locale di piccole dimensioni, con un bancone nel quale erano incassate grosse anfore di terracotta, chiamate dolii o dolia, atte a contenere le vivande. Il thermopolium viene descritto in vari testi, e soprattutto venne suo malgrado immortalato dall'eruzione vulcanica del Vesuvio: a Pompei ne esiste uno quasi integro, e altri due tra le rovine di Ercolano e di Ostia Antica. Avevano inequivocabilmente una funzione simile ai moderni bar. Si parte quindi dai Romani, attraverso le sporche bettole medioevali e le fumose locande rinascimentali, per arrivare ai bar e pub moderni, oggi perfetta fusione di mondanità e comfort.
Ma da dove deriva la parola "bar"? Si fanno molte ipotesi. Secondo alcuni "bar" sarebbe una contrazione di "barrier", ovvero "sbarra" in inglese, il bancone che divide il gestore dalla clientela. In Italia invece la parola bar sarebbe l'acronimo di "Banco A Ristoro", introdotto a Firenze sul finire del 1800. "Pub" invece sta per public house (edificio pubblico), denominazione dei locali per antonomasia del Regno Unito, e poi diffusi in tutto il mondo. E' d'uopo però fare un salto indietro nel tempo, e partire dal predecessore dei "bar" o "pub" moderni: il "caffè". Affinché la bevanda da bar per eccellenza, il caffè, approdasse in questi esercizi, bisogna far riferimento alla civiltà turca. Già nel 1500, in Medio Oriente, si consumavano the e caffè in alcuni luoghi di ritrovo, e davanti alle tazze fumanti si incontravano artisti e uomini d'affari. Un concetto di "luogo aperto", dove vedersi lontano da casa, per consumare bevande pregiate e ridere, pensare e discutere, che fu importato in "occidente" a cavallo tra il 1600 ed il 1700. È in quegli anni che fanno la loro comparsa a Vienna, in Austria, e a Venezia, in Italia, le prime caffetterie, divenute poi celebri anche a Padova, Firenze e Roma. Il boom si ebbe soprattutto quando il Papato abolì il divieto di consumare il caffè. All'Italia, seguì poco tempo dopo anche la Francia, con Parigi. Nel 1900 in Italia iniziò a scomparire la scritta "Caffè" a favore di "Bar". Da luogo elitario divenne sempre più popolare: qui si riunivano non solo politici, attori ed artisti, ma anche persone di ogni ceto sociale. Fu definitivamente scelto dagli italiani come luogo chiave per cominciare la giornata negli anni del boom economico; tra il 1950 e il 1960 andavano tutti di corsa a lavorare e si passava al bar per gustare un caffè veloce per poi scappare via.
Come sopra detto, sin dal XVI secolo, le caffetterie (qahveh-khaneh in persiano) hanno assolto la funzione di luogo di intrattenimento socializzante nelle regioni del medio oriente, dove gli uomini si riunivano per consumare caffè o tè, ascoltare musica, leggere e per ascoltare narrazioni. Nel XVII secolo i caffè apparvero per la prima volta in Europa attraverso i porti del Mediterraneo che commerciavano con il medio oriente, come Venezia e Marsiglia, e attraverso i porti del Mare del Nord che dominavano il commercio mondiale, come Londra e Amsterdam. Questi locali d'incontro e socializzazione divennero ben presto i luoghi di ritrovo preferiti per filosofi e studiosi, per artisti e politici. Il Settecento fu il "periodo d'oro" dei caffè europei: essi erano il ritrovo della emergente borghesia in opposizione ai salotti aristocratici ed ovviamente alle osterie e birrerie popolari. I caffè furono quindi i luoghi centrali nella vita commerciale e culturale delle città europee, dove si svilupparono i principali aspetti della società borghese. Nel 1739 si contavano ben 551 coffee house nella sola città di Londra. Ognuno di essi richiamava una determinata categoria di frequentatori; in alcuni si ritrovava il mondo politico, in altri quello commerciale, bancario o assicurativo, in altri ancora il mondo letterario ed artistico. Similmente, alla fine del Settecento a Parigi c'erano quasi 3.000 cafés. Anche i caffè italiani furono luoghi di discussioni letterarie e politiche, tanto che la più importante rivista dell'Illuminismo italiano si chiamava proprio Il Caffè. In molti paesi europei alle donne era vietato l'ingresso nei caffè: in Germania era loro consentita la frequentazione, ma in Francia ed in Gran Bretagna alle signore era vietato entrare in questi locali. Invece a Venezia le signore li frequentavano abitualmente.
Nell' Ottocento e nel Novecento i Caffè hanno visto una lenta progressiva evoluzione sia funzionale che stilistica. Iniziarono ad aprire molti nuovi caffè eleganti in tutta Europa, nei luoghi più belli e di richiamo delle città. In questo periodo ad esempio nacquero i caffè viennesi con la loro atmosfera tranquilla ed i loro rituali (famoso il Sacher), come pure i caffè parigini, dotati di grandi vetrine e terrasses dove sedere indisturbati al tavolino osservando la vita cittadina (il Café de la Paix esiste tuttora). In Italia furono soprattutto le piazze a riempirsi dei tavolini dei caffè: sotto i portici della piazza principale di tante città e cittadine esercitavano la propria attività almeno due caffè "rivali", i cui nomi si ripetevano simili da una cittadina all'altra, come "Caffè Nazionale" e "Caffè Commercio". Proprio nel Novecento, nella Belle Epoque, molti locali europei frequentati dai più grandi letterati ed artisti del mondo (Picasso, Hemingway, ecc.) sono diventati simboli della storia intellettuale mondiale, veri e propri monumenti dell'evoluzione dell'uomo. In Italia i caffè sono rimasti in auge fino alle soglie del "miracolo economico" degli anni '60. Successivamente i caffè storici sono sopravvissuti, ma non ne sono stati più aperti di nuovi; nel contempo si affermavano altri tipi di esercizi, in particolare i bar, che (in Italia) si sono specializzati nella preparazione del caffè espresso servito al bancone.

E si arriva così al Duemila. Nel mondo il "Bar" prende piede in modo perentorio, con le sue varie "specializzazioni". In Italia il cosiddetto "Bar all'italiana", in grande auge sino alla fine del secolo scorso, perde via via le sue prerogative del dopoguerra (il gioco delle carte, il tavolo da biliardo, la ricevitoria di lotterie, i giochi elettronici, ecc.). I locali si modernizzano, la clientela si ringiovanisce drasticamente, gli esercizi e gli arredi diventano più eleganti e funzionali, più inclini alla redditività, pur rimanendo i luoghi di aggregazione sociale più ambiti. A cavallo tra il XX e il XXI secolo in viarie parti del mondo si è assistito alla nascita di bar tematici e stravaganti, come ad esempio in Giappone i manga café dedicati ai fumetti o i neko café che offrono ai clienti la possibilità di interagire con i gatti ospitati dal locale. Altri bar, oltre alle classiche consumazioni, danno alla clientela la possibilità di accedere a servizi specifici, come gli americani: Internet cafè, con dotazioni di computer, gay bar, rivolti ad un pubblico omosessuale, topless bar, in cui le cameriere servono i clienti a seno scoperto, lounge bar, eleganti e con dotazione di intrattenimento musicale, e innumerevoli altre varianti. L'american bar, destinato principalmente al consumo di cocktail, si è un po' defilato.
I bar europei li conosciamo bene, ma è così ovunque nel resto del mondo non occidentale? Australia. In Australia, la principale forma di vendita commerciale di alcolici autorizzata dal periodo coloniale ad oggi è stata il pub, una variante locale dell'originale pub inglese. Fino agli anni '70, i pub australiani erano tradizionalmente organizzati in aree per bere divise per genere: il pub era aperto solo agli uomini, mentre i "lounge bar" o i "saloon bar" servivano sia uomini che donne (cioè bevande miste). Questi locali furono molto popolari tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70 e molti offrivano intrattenimento gratuito, diventando un aspetto importante della scena musicale di Sydney in quel periodo. Nelle principali città australiane oggi c'è una scena di bar ampia e diversificata con una gamma di ambienti, modalità e stili adatti a ogni livello della sua società cosmopolita. Cina. Se pensate di andare in Cina e, tra un'escursione e l'altra, potervi avvalere del breve ristoro di un bar, scordatevelo. In Cina i bar non sono mai esistiti e non esistono tuttora, salvo ovviamente i locali di chiaro stampo europeo realizzati nelle città maggiori per accogliere il turismo. La civiltà cinese ora avanza in modo travolgente, ma, dopo il crollo dell'epoca maoista che aveva azzerato il periodo opulento del colonialismo europeo, per la ristorazione siamo agli albori. India. Col suo miliardo e mezzo di abitanti pareggia la Cina, ma qui il colonialismo inglese non ha mai perduto certe sue prerogative. Si perde il conto dei locali popolari in ogni centro urbano, con livelli estetici ed igienici discutibili; locali però più dedicati a forme di ristorazione spicciola e spartana che non ha luoghi esclusivamente di ritrovo. Ad essi si affiancano ovunque locali di eccellente livello, riservati alla fascia sociale più abbiente. Africa. Qui si trovano i "bar" più coloriti, quelli che conducono al buonumore. Sorgono lungo le rare arterie stradali. Un tavolo a far da bancone, una ghiacciaia come frigo in quelli più all'avanguardia, e tre-quattro tipi di bibite in lattina come scelta per gli avventori, in genere Coca-Cola e birra. Latte di noci di cocco e banane come corollario. Nella povera società subequatoriale africana, in cui il concetto di "ritrovo" è inglobato nella vita comunitaria del villaggio, il termine "bar" non racchiude alcun significato, se non quello di fonte di "guadagno" dai rari viandanti o turisti.
Tornando a noi, come saranno i bar del nuovo millennio? Non si sa, ma certamente quello che avrà il successo più travolgente sarà il primo che verrà aperto nello spazio.
62°FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONALE DI BRESCIA E BERGAMO
- Dettagli
- Scritto da Marco Morelli

Dopo aver dedicato a Vienna l'edizione 2024, il Festival Pianistico annuncia il tema e il cartellone principale della sua 62esima edizione. Per l'edizione 2025 il titolo scelto, Noches de España, non lascia dubbi sull'area che il Festival esplorerà dal 28 aprile al 26 giugno: il 62° Festival sarà infatti la prima parte di un percorso triennale che percorrerà il continente europeo.
"Il Festival entra nel 2025 forte di una crescita costante che ha fatto registrare quest'anno il sorpasso dei numeri pre-pandemia, con oltre 1000 abbonati e più di 10.000 biglietti venduti, traguardo che non raggiungeva dal 2019 - dichiara la Presidente Daniela Gennaro Guadalupi - Un bilancio dunque molto positivo, risultato di un'offerta culturale originale, premiata dal pubblico e possibile grazie al sostegno delle istituzioni pubbliche e dei privati, che permettono di perpetuare la tradizione di eccellenza del Festival anche per il 2025". Intesa Sanpaolo sarà sempre al fianco del Festival come Main Partner.
Il tema: Noches de España
Protagonista per la prima volta di un'edizione del Festival, il paese latino per eccellenza ha da sempre esercitato un fascino quasi esotico tra i compositori europei. Partendo dalle opere pianistiche più importanti del mondo spagnolo, Iberia di Albéniz, Goyescas di Granados, Noches en los jardines de España di Manuel de Falla, che rappresentano l'anima e le tradizioni di questa nazione, il Festival alternerà "cartoline musicali" di compositori che non ebbero legami diretti con la Spagna, pur evocandola musicalmente all'interno delle loro opere – Čajkovskij, Rimsky-Korsakov, Liszt e Debussy per citarne alcuni – ed autori che invece respirarono le "notti spagnole", quali Ravel, Chopin e Scarlatti.
Omaggio ad Arturo Benedetti Michelangeli nel trentennale della scomparsa
Nel 2025 il Festival ricorderà i 30 anni dalla morte di Arturo Benedetti Michelangeli, dedicandogli quest'edizione. "Come è noto, il nostro Festival nasce nel suo nome e la sua eredità artistica è più viva che mai – dichiara il direttore artistico Pier Carlo Orizio – Vorrei ricordarlo in questa sede per un aspetto forse marginale del suo repertorio, ovvero la predilezione per alcuni brevi brani spagnoli che fortunatamente sono disponibili in rete. Sono: Malagueña di Albéniz, Andaluza di Granados e Cancion di Federico Mompou. Brani che un pianista dilettante esegue senza troppo impegno, acquistano con Arturo Benedetti Michelangeli il valore dell'arte assoluta".
Il cartellone del 62°Festival
Tra gli interpreti internazionali che calcheranno i palchi di Brescia e Bergamo, il 62°Festival vedrà l'atteso ritorno di Hélène Grimaud, Yulianna Avdeeva, Jan Lisiecki e Alexandra Dovgan. Tra le orchestre debuttano, la Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pflaz e la Neojiba Orchestra (Orchestra Giovanile dello Stato di Bahia), che si esibirà in esclusiva italiana a Brescia e Bergamo con il duo pianistico Arthur e Lucas Jussen.
L'inaugurazione del 62°Festival, di cui Intesa Sanpaolo sarà Presenting Partner, si terrà al Teatro Grande di Brescia lunedì 28 aprile e il giorno successivo a Bergamo con la Slovenian Philharmonic diretta da Kakhi Solomnishvili con solista Pierre-Laurent Aimard. Il programma rifette a pieno il tema di Noches de España con la Rapsodia spagnola, il Concerto in re per la mano sinistra e l'iconico Bolero di Ravel, a cui si aggiunge il Capriccio spagnolo di Rimsky-Korsakov.
Altra tappa fondamentale quella con la Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pflaz, diretta da Pier Carlo Orizio con la pianista Ying Li, che propone una selezione da Iberia di Albéniz, Noches en los Jardines de España di de Falla e i Quadri di un'esposizione di Musorgskij/Ravel.
In esclusiva italiana e prima volta al Festival si esibisce l'orchestra brasiliana Neojiba – progetto dalla forte vocazione sociale, raccoglie infatti musicisti di età compresa tra i 13 e i 27 anni – diretta da Ricardo Castro con solisti Arthur e Lucas Jussen, rinomato duo di pianisti olandesi allievi di Maria João Pires, al loro debutto al Festival. Il programma è dedicato alla musica latinoamericana con il pezzo contemporaneo Nazareno per due pianoforti e orchestra di Golijov, accanto a brani di Gomes, Bernstein, Copland e Ginastera.
Due gli appuntamenti con Hélène Grimaud, che ritorna al Festival a distanza di tre anni dalla sua prima, apprezzatissima, apparizione: l'8 maggio al Donizetti accompagnata dalla Camerata Salzburg nel Concerto in re min e nella Serenata in re mag di Brahms; e domenica 1 giugno in recital al Grande con in programma la Sonata op.109 di Beethoven, i Tre Intermezzi, le Sette Fantasie di Brahms op.116 e la Ciaccona di Bach/Busoni.
A 10 anni di distanza torna al Festival anche un'altra grande pianista internazionale, Julianna Avdeeva, con un programma tutto dedicato a Chopin. Sempre Chopin - che a Palma di Maiorca compose i Preludi - ritorna anche nei programmi di due giovani pianisti, da anni lanciati sulla scena mondiale: Jan Lisiecki e Lucas Debargue, già ospiti a Brescia e Bergamo negli scorsi anni.
Debutto al Festival per un affermato interprete spagnolo, Javier Perianes con un recital in ricordo di Alicia de Larrocha (1923-2009), ospite per ben 6 volte al Festival.
Presenza fissa nel cartellone di entrambe le città quella di Grigory Sokolov il 17-19 maggio. In cartellone anche i recital di due affezionati interpreti, rispettivamente a Brescia il 30 aprile Federico Colli e a Bergamo il 3 giugno Giuseppe Albanese.
Chiude il cartellone principale la diciassettenne Alexandra Dovgan, talentosa pianista che il Festival presentò per primo in Italia nel 2019 a soli undici anni, solista con i Wiener Kammerorchester diretti da Pier Carlo Orizio in un tutto Beethoven con l'ouverture Coriolano, il Concerto per pianoforte n.4 e la Settima Sinfonia.
Nel 2025 inoltre il Festival sarà partner del progetto che unirà le due città, su iniziativa delle Camere di Commercio, di Visit Brescia, di Visit Bergamo e delle Curie diocesane, in occasione del Giubileo "Pellegrini di speranza".
Oltre al cartellone principale torneranno le altre rassegne collaterali, che verranno svelate nei prossimi mesi. Sul sito (www.festivalpianistico.it) è possibile scaricare il calendario del 62°Festival con tutti i programmi nel dettaglio.
USA, NUOVE PROSPETTIVE SUL CONSUMO DI ALCOL E SALUTE
- Dettagli
- Scritto da Marco Morelli
 Il dibattito negli Stati Uniti sul legame tra consumo di alcol e salute si arricchisce di nuovi elementi grazie al rapporto "Review of Evidence on Alcohol and Health" della National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM), uno dei più autorevoli organi scientifici statunitensi, che presenta una revisione completa delle evidenze scientifiche sugli effetti del consumo di alcol sulla salute. Questo studio, tra i più importanti nel panorama scientifico internazionale, fornisce una revisione approfondita delle evidenze disponibili sugli effetti del consumo di alcol, distinguendo in modo chiaro tra consumo moderato e abuso.
Il dibattito negli Stati Uniti sul legame tra consumo di alcol e salute si arricchisce di nuovi elementi grazie al rapporto "Review of Evidence on Alcohol and Health" della National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM), uno dei più autorevoli organi scientifici statunitensi, che presenta una revisione completa delle evidenze scientifiche sugli effetti del consumo di alcol sulla salute. Questo studio, tra i più importanti nel panorama scientifico internazionale, fornisce una revisione approfondita delle evidenze disponibili sugli effetti del consumo di alcol, distinguendo in modo chiaro tra consumo moderato e abuso.
Il rapporto evidenzia come un consumo moderato di alcol possa essere associato a benefici cardiovascolari e a una riduzione del rischio di mortalità generale. Tuttavia, conferma anche un aumento del rischio di tumore al seno e sottolinea la necessità di ulteriori ricerche per approfondire il legame con altre patologie oncologiche.
La NASEM, istituita nel 1863 con un atto del Congresso firmato dal Presidente Abraham Lincoln, rappresenta il punto di riferimento scientifico per il governo statunitense. Le tre accademie che la compongono – National Academy of Sciences, National Academy of Engineering e National Academy of Medicine – collaborano per fornire analisi scientifiche indipendenti e guidare le politiche pubbliche su temi complessi di salute, tecnologia e ingegneria.
Il rapporto è stato elaborato seguendo una metodologia scientifica rigorosa: le conclusioni sono il frutto di un processo di consenso tra esperti, sottoposto a peer review da parte di dieci scienziati indipendenti, e costituiranno la base delle future Dietary Guidelines for Americans in materia di nutrizione. L'analisi approfondisce gli effetti del consumo di alcol su diversi aspetti della salute pubblica, adottando un approccio differenziato tra consumo moderato ed eccessivo. Il rapporto completo è disponibile al seguente link: https://nap.nationalacademies.org/catalog/28582/review-of-evidence-on-alcohol-and-health
I principali risultati del rapporto NASEM
Riduzione del rischio di mortalità generale: secondo il rapporto, il consumo moderato di alcol (≤14 g/die per le donne, ≤30 g/die per gli uomini) è associato a una riduzione del 16%
del rischio di mortalità generale rispetto ai non consumatori. Nelle donne, questa riduzione raggiunge il 23%, principalmente per i benefici cardiovascolari.
Benefici cardiovascolari: il consumo moderato risulta protettivo nei confronti di malattie cardiovascolari, con una riduzione significativa di infarto miocardico e ictus ischemico. L'effetto protettivo sembra legato all'aumento del colesterolo HDL (colesterolo "buono") e a una migliore funzione endoteliale.
Rischio oncologico: il rapporto conferma un'associazione tra consumo moderato di alcol e aumento del rischio di tumore al seno, senza una soglia di sicurezza identificata. Per altri tipi di tumore, come il colon-retto, le evidenze sono meno solide e richiedono ulteriori approfondimenti. I principali rischi oncologici risultano legati a un consumo eccessivo e prolungato di alcol.
Assenza di evidenze su demenza: non emergono prove scientifiche di una correlazione tra consumo moderato di alcol e rischio di demenza senile. Tuttavia, il rapporto evidenzia la necessità di ulteriori studi per chiarire eventuali relazioni con il declino cognitivo.
Distinzione tra consumo moderato e abuso: il rapporto sottolinea l'importanza di distinguere tra consumo moderato ed eccessivo. I principali rischi per la salute, inclusi i sette tipi di tumore associati all'alcol, sono strettamente legati all'abuso e non al consumo moderato.
Questa revisione introduce una prospettiva più articolata rispetto alle posizioni più allarmistiche adottate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dal Surgeon General USA, evidenziando con maggiore chiarezza la distinzione tra consumo moderato e abuso di alcol. Il rapporto NASEM ribadisce, inoltre, l'importanza di condurre ulteriori studi per approfondire il legame tra consumo moderato di alcol e il rischio di specifiche patologie, al fine di colmare le attuali lacune conoscitive. Le evidenze emergenti potranno contribuire a definire raccomandazioni più dettagliate e mirate nelle future Dietary Guidelines for Americans, supportando lo sviluppo di politiche di salute pubblica fondate su dati scientifici aggiornati e rigorosi.
Commentando il rapporto, il Prof. Attilio Giacosa, presidente di IRVAS (Istituto per la Ricerca su Vino, Alimentazione e Salute), ha dichiarato: «Il rapporto della National Academies of Sciences propone un'analisi scientifica più equilibrata sul consumo di alcol, distinguendo in modo chiaro tra consumo moderato e abuso. I principali rischi per la salute emergono infatti in relazione a un consumo eccessivo e prolungato. Allo stesso tempo, il rapporto evidenzia la necessità di approfondire ulteriormente i potenziali rischi associati al consumo moderato, in particolare per alcune patologie oncologiche. Questo approccio si discosta dalla posizione più cautelativa del Surgeon General USA, che estende il rischio a qualsiasi livello di consumo senza distinzione. È fondamentale, invece, differenziare tra
consumo moderato e abuso per affrontare il tema in modo rigoroso e basato su evidenze scientifiche. Le politiche di salute pubblica devono riflettere questa complessità, promuovendo un'informazione chiara e completa che consenta ai cittadini di compiere scelte consapevoli e responsabili. Se da un lato la ricerca scientifica deve continuare a indagare i possibili rischi legati al consumo moderato di alcol, dall'altro è essenziale evitare di demonizzare comportamenti che, se inseriti in uno stile di vita sano ed equilibrato, possono non comportare effetti negativi. Serve equilibrio e responsabilità, tanto nella comunicazione quanto nell'elaborazione delle politiche di salute pubblica».
NUOVA eBIKE MARATHON
- Dettagli
- Scritto da Marco Morelli
 FSA Bike Festival di Riva del Garda, dal 1° al 4 maggio, presenta una novità assoluta: la eBike Marathon che si terrà sabato 3 maggio – lo stesso giorno della tradizionale MTB Bike Marathon – con partenza alle 7.55 nel cuore del centro storico di Riva del Garda. Possono partecipare eBike con una velocità non superiore ai 25 km/h. Il formato non è competitivo, rispettando lo spirito "Riding Freedom" del Bike Festival 2025: l'obiettivo principale è divertirsi e vivere l'esperienza del più famoso evento dell'expo gardesano senza la pressione di una graduatoria finale.
FSA Bike Festival di Riva del Garda, dal 1° al 4 maggio, presenta una novità assoluta: la eBike Marathon che si terrà sabato 3 maggio – lo stesso giorno della tradizionale MTB Bike Marathon – con partenza alle 7.55 nel cuore del centro storico di Riva del Garda. Possono partecipare eBike con una velocità non superiore ai 25 km/h. Il formato non è competitivo, rispettando lo spirito "Riding Freedom" del Bike Festival 2025: l'obiettivo principale è divertirsi e vivere l'esperienza del più famoso evento dell'expo gardesano senza la pressione di una graduatoria finale.
L'itinerario si sviluppa su una distanza di 48 chilometri con un dislivello di circa 1.700 metri e combina elementi di due tracciati della Bike Marathon, la Ronda Piccola e la Ronda Grande. Con una quota di iscrizione di 50,00 €, i partecipanti alla eBike Marathon riceveranno gli stessi servizi degli iscritti alla Bike Marathon.
Le iscrizioni sono aperte su eBike Marathon Bike Festival Riva del Garda
Bosch eMTB Challenge: una nuova categoria Pro e percorso rinnovato
La Bosch eMTB Challenge offre un mix variegato di salite, discese e orientamento ed è pensata per regalare un'esperienza entusiasmante a tutti gli eBiker, che possono scegliere fra tre categorie. La nuova categoria "Pro" per professionisti prevede un ulteriore segmento rispetto alla "Advanced" per i rider esperti, per un totale di sette prove speciali in cui la sezione aggiuntiva sarà particolarmente impegnativa in termini di distanza e dislivello. La terza categoria "Amateur" comprende cinque frazioni a tempo, con una difficoltà tecnica più bassa.
Rispetto alla passata edizione, i partecipanti affronteranno un percorso completamente nuovo, che offrirà alcuni dei migliori sentieri e panorami nell'entroterra del Garda Trentino. La mappa del tracciato sarà annunciata solo al momento della partenza, prevista venerdì 2 maggio alle 9:30, quando sulla linea di partenza saranno presenti circa 300 rider. Alla fine, la spunteranno gli eBiker più potenti e versatili, perché alla Bosch eMTB Challenge non contano solo la resistenza e la potenza del motore, ma soprattutto la tecnica di guida e l'orientamento.
Le iscrizioni sono aperte su Bosch eMTB Challenge
Tour guidati: quattro tour al giorno con tre livelli di difficoltà
Il programma del Bike Festival prevede quattro tour guidati al giorno. Le escursioni, che partono dall'area Expo e sono ideali per esplorare il Garda Trentino, sono adatte a tutti, potendo scegliere tre diversi livelli di difficoltà.
La "Mega Marrocche", di livello facile, presenta un percorso rilassante con un mix di esperienza nella natura e divertimento in sella. Il momento clou del tour è la salita verso il Lago di Cavedine, con vista sulla Valle del Sarca.Il tour di livello medio "San Pietro" è pensato per chi vuole mettersi alla prova senza esagerare. Dopo una salita attraverso i boschi del Garda Trentino, si raggiunge il rifugio San Pietro, un belvedere con una vista impareggiabile sul Lago di Garda settentrionale.
Infine, nel livello avanzato, il tour "Close to the Sky" si sviluppa su dei trail maggiormente impegnativi con tanti metri di dislivello e alte dosi di adrenalina. Il tour include il leggendario Ponale Trail, il Lago di Ledro e le montagne circostanti, con una discesa spettacolare verso Punta Larici, uno dei punti panoramici più belli della regione.
Le iscrizioni sono aperte su Bike Festival Riva Experience
MTB School e MTB Skill Park: tutti sui banchi di scuola
Un'ulteriore novità di quest'anno è la MTB School, una sessione tecnica nel nuovissimo MTB Skill Park Busatte all'interno del Parco Busatte, progettato per ciclisti di tutti i livelli che vogliono migliorare la propria tecnica sui sentieri.
Ulteriori informazioni: www.bikefestivalriva.com
Altri articoli...
- ReUse: Il Futuro del Riciclo, la Rigenerazione della Gomma ovvero trasformare lo scarto di Gomma vulcanizzata in una Risorsa Sostenibile
- La Mantova-Milano senza nuovi convogli fino al 2026. I pendolari di InOrario protestano con Trenord e l’assessore Terzi
- “WITHOUT FRONTIERS, LUNETTA A COLORI”
- GIUSEPPE DE DONNO. A TU PER TU COL PLASMA IPERIMMUNE